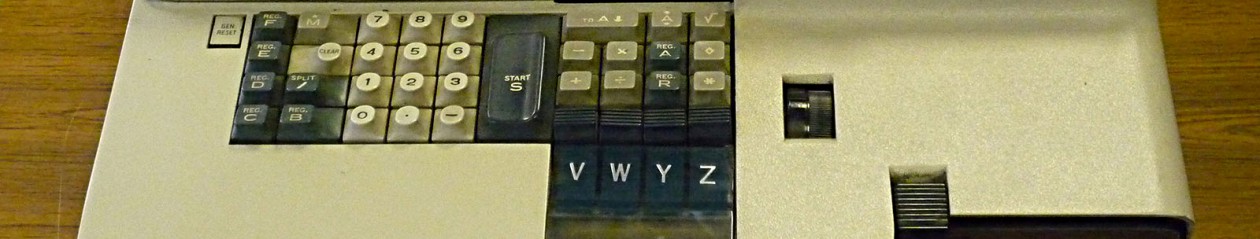Revisione testo: 23 luglio 2021 – Il diritto familiare dei Galli d’Italia (Celti), che si è in parte sovrapposto al diritto venetico, presuppone un’autorità paterna molto più rigida della patria potestà romana. In alcuni documenti infatti, per distinguere i figli, non si usa l’appellativo che noi definiremmo cognome ma il nome del padre effettivo. Inoltre, secondo il costume celtico, il potere del padre era talmente grande che il suocero era formalmente ‘marito’ della nuora, anche se non praticamente.
Lo sposo, finché era vivo suo padre, era figlio di famiglia e quindi solo sposo ma non marito, con la conseguenza cioè che la moglie forse poteva anche giacere col suocero ma, fin che il suocero stesso fosse stato vivo, non certamente col marito. Questo si usava a Brescia ma non a Verona: è famosa infatti una documentazione in tal senso scritta da Catullo (84 a.C – 54 a.C., che era veronese) dove egli non si capacita di come a Brescia potesse esservi un’usanza del genere. In questo, noi siamo imbevuti di diritto romano e non concepiamo l’usanza del suocero, che fa da pre-marito alla nuora sino alla morte del suocero stesso. Le accuse di Catullo erano però spinte al fatto che il suocero ‘approfittava effettivamente’ di questa usanza (prelibazione) e non solo formalmente. Ma Verona era stata cenomana (galli cenomani) e solo negli ultimi tempi il diritto latino era prevalso. La data di nascita di Catullo ci dice quanto recente fosse ancora la suddivisione dei costumi tra Brescia, ancora celtica, e Verona, ormai venetico-romanizzata. Diritti diversi quindi, lingue diverse, sovrapposizione parziale nel tempo e nello spazio sia delle lingue che dei costumi. L’immagine migliore è quella di un pentolone in ebollizione, dove tutto si muove e tutto può cambiare: tutti noi, per capire meglio, preferiremmo qualcosa di nitido ma così non è nella storia umana.
Riassumendo, nell’unità veneta abbiamo un fondo euganeo (in parte ligure) con mescolanze retiche (a loro volta i reti erano vecchi abitanti etruschi imbarbariti dopo che si erano sottomessi ai Galli Transalpini) e poi sopravvenne la romanizzazione. Verona è il miscuglio dei miscugli: dapprima euganeo-ligure (quindi a base venetica), poi retica, poi cenomana e, come abbiamo visto, alla fine romana. Il Friuli invece è molto più influenzato dal mondo retico (ex-etruschi sottomessi dai galli transalpini) e dal mondo dei karni (della Carnia, galli senza influsso etrusco). Tali differenze danno origine al nucleo linguistico reto-romanzo che a sua volta, col nome di ladino, si espanse addirittura sino all’attuale cantone dei Grigioni in Isvizzera. Ricordiamo nuovamente che il nome ‘galli’ è l’appellativo generico dato dai romani a tutte le tribù celtiche.
Noi siamo quindi molto più etruschi di quanto si possa pensare e in quel di Verona le tracce etrusche sono rilevanti, senza parlare del sud del Veneto (Este, Mantova ecc.), dove sono più rilevanti ancora.
Poi, il sollevamento del fondo marino contribuì a cambiare il destino di Altino e Concordia, modificando l’assetto della fascia costiera a cui accennavamo precedentemente. Inoltre il Po ha portato, in 2500 anni, verso il delta, 25 chilometri di detriti, 10 centimetri all’anno. Adria era un (‘il’ porto: ha dato infatti il nome al mare) porto sull’Adriatico ai tempi di Gesù Cristo ed ora si trova appunto a 25 chilometri dal mare. Incredibile.