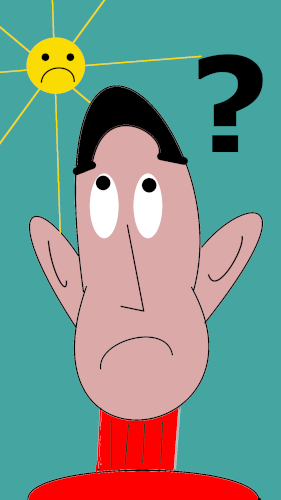
Revisione del testo: 17 ottobre 2021 ore 15:20 – Revisione delle immagini: 15 ottobre 2021. – Il racconto è un racconto in parte umoristico ed in parte non troppo coerente: serve per evidenziare l’uso dei modi di dire. Nell’ultima parola di ogni modo di dire, si trova un apice0 che rimanda ad una nota alla fine dell’articolo, la quale cerca di spiegare il modo di dire stesso. Sono omessi i modi di dire banali del tipo ‘mi faceva gli occhi dolci ’, dove il modo di dire si spiega da sé.
Inizio del racconto: Le avventure di un avventuroso.
In quel periodo, quando mi svegliavo al mattino, avevo sempre la luna storta1. Avevo un periodo in cui, per un’ora buona dopo la sveglia, le gambe mi facevano giacomo-giacomo2. Studiavo all’università e non ero indipendente finanziariamente: ero sempre al verde3 e prima di uscire dovevo battere cassa4 dai miei genitori. Qualche volta, mi dicevano: “Visto che all’ università vai abbastanza bene, facendo i conti, possiamo darti qualcosa in più…”. Io rispondevo con un sorrisone: “Magari5… vi ringrazierei infinitamente: questo supplemento cadrebbe a fagiolo6 perché dovrei comperare un libro di matematica… non so bene quanto costi ma, ad occhio e croce7, costerà 60 euro…”:
Mio padre una volta rispose: “Sei al penultimo anno di università e sei un bravo figliolo… ti meriti un aiuto. Fin qua, siamo arrivati…” poi, guardando mia madre, aggiunse: “Abbiamo fatto trenta… facciamo trentuno8”. Non dissi ai miei che, visti miei voti ed il mio impegno, i professori avevano concordato di farmi laureare un anno prima. Per tutto il periodo universitario, i docenti si erano accorti con piacere che cercavo di bruciare le tappe9 ed avevano cercato di favorirmi, perché sapevano che la mia famiglia non nuotava nell’oro10.
Quella mattina, scendendo le scale col proposito di andare in libreria, incontrai Morena, proprio sulle scale del condominio, nel quale abitava anche lei. Bellissima ragazza, alla quale ero molto simpatico ma io dovevo studiare e Morena mi attaccava dei bottoni11 incredibili. Mi guardava con aria sognante e mi diceva: ‘Il mio sogno è sposare una persona in gamba12 come te…’. Ed io rispondevo:

“Fino a quando non mi sarò laureato e non avrò trovato un lavoro, il matrimonio, per me, sarà come inseguire una chimera13… comunque, Morena, sei una bellissima ragazza, mi piaci molto e al momento opportuno, se vorrai, ti chiederò di sposarmi”. Morena diceva, sorridendo: “Davvero?” ed io: “Sì, davvero, ma per adesso, acqua in bocca14 ”.
In verità, io ero sincero… tuttavia, segretamente… mi piaceva molto la figlia del fornaio, una ragazza bionda che però non si accorgeva nemmeno che io esistessi. Pensai che, tutto sommato, Morena potesse risolvermi il problema: chiodo scaccia chiodo…15.
Morena disse: “Vedo però che fai il cascamorto16 con la figlia del fornaio…”
[segue]
====================================================
Spiegazione delle note.
====================================================
- Luna storta. I modi di dire che hanno a che fare con la Luna (basti pensare al fatto che lunatico è sinonimo di volubile) vengono spesso da antiche credenze, secondo le quali le fasi lunari avevano, senza alcun fondamento scientifico, un’influenza sul comportamento delle persone. La luna quindi, già da dritta, genera sensazioni negative: figuriamoci se è anche storta…
- Si parla di due origini per la frase ‘Gambe che fanno giacomo ‘, che significa ‘ho le gambe che mi si piegano, che non mi sostengono’:
- nel 1358, durante la Guerra dei Cento Anni, in Francia si sollevò una rivolta contadina, dovuta al peso delle tasse (nel 1348 c’era stata la peste e il mondo stava cambiando). I contadini indossavano, a quei tempi, la cosiddetta ‘Jacque’, [giacca], una giacchetta di un povero tessuto, che non teneva affatto caldo, per risparmiare sul cappotto lungo e caldo, dato che i tessuti costavano un’enormità. Gli aristocratici presero spunto da questo tipico vestiario per identificare i contadini in modo dispregiativo, con l’espressione ‘Jacques bonhomme’ [Giacomo buon uomo] che assunse il significato di ‘vigliacco’ o ‘imbecille’. In seguito, in Francia si diffuse il modo di dire ‘Faire le Jacques’, che si può tradurre in italiano come ‘fare lo sciocco o fare il vigliacco’, indicando le gambe dei contadini che tremavano dalla paura davanti alle milizie. Osservazione: il canone natalizio fra’ Martino campanaro, dormi tu? suonan le campane, din don dan…, viene dalla Francia ed il testo francese recita: Frère Jacques, dormez-vous… ‘, il testo francese è, probabilmente, una reminiscenza del modo di dire ‘Faire le Jacques’: stessa metrica, stessa assonanza, stesso ritmo.
- Il Cammino di Santiago è un famoso cammino (come la via Francigena, che porta a Roma) dei pellegrini, che attraversa la Francia e la Spagna ma anche il Portogallo (dipende da quale tragitto si vuole compiere) che va sino a Santiago de Compostela, una città spagnola che si trova in Galizia, nella Spagna nord-occidentale, dove sorge un santuario, meta di pellegrinaggio sin dal Medioevo. Per la lunghezza del percorso, circa 800 km, i viaggiatori arrivano con le gambe molto stanche. Si arriva così al Santuario di Santiago (in castigliano, cioè spagnolo), ossia al Santuario di San Giacomo (in italiano). Le gambe, allora, fanno ‘ giacomo ‘.
- Varie sono le spiegazioni per l’espressione ‘Essere al verde‘. Accenniamo ad alcune:
- Deriverebbe da un’antica usanza medievale, che consisteva nel far portare un berretto verde ai falliti, in segno di pubblico scherno.
- Nelle aste pubbliche del Magistrato del Sale di Firenze, si adoperavano delle lunghe candele di sego tinte di verde nell’estremità inferiore: quando la candela arrivava “al verde”, l’asta si chiudeva. Oppure, poiché i poveri non avevano soldi per comperare una candela nuova quando essa era finita, la utilizzavano fino alla base, che, un tempo, era sempre di color verde. Da qui sarebbe nata l’espressione “la candela è al verde”, per indicare che il tempo era finito, ma anche “essere al verde di denari”, che in seguito, nell’uso comune, si sarebbe contratta nell’ attuale ‘essere al verde’.
- Forse, a nostro avviso, la seguente è la più probabile: a Padova si dà per certa l’origine della frase dalla ‘sala verde ‘ dell’antico Caffè Pedrocchi, dove, per antica tradizione, chiunque può accomodarsi senza consumare.
- Altri sostengono che l’espressione è nata nelle case da gioco. Il giocatore che ha perso tutte le sue fiches [gettoni], quando guarda il punto dove teneva il proprio gruzzoletto, vede solo il tavolo da gioco, tradizionalmente verde.
- Sembra che si dica ‘Battere cassa‘ perché un tempo, quando il denaro era ancora in monete di metallo, lo si conservava in forzieri o, più modestamente, in cassette. Bastava scuotere la cassetta per capire se fosse vuota oppure no. Il detto sembra però derivare dal gesto dei questuanti, che per chiedere un obolo agitavano o percuotevano una cassetta facendo tintinnare le monete che conteneva. Si batteva la cassetta, ovvero la cassa, per far capire che si necessitavano soldi.
- Magari viene dal greco makàrie, vocativo di makàrios [felice]. Equivale a ‘ne sarei felice’. Come tutte le parole greche, le vie d’accesso sono due: La prima via di accesso è la Magna Grecia, ovvero l’Italia meridionale, da dove le parole si dipartivano per Roma. La seconda via, in tempi successivi, è l’esarcato di Ravenna, appartenente all’impero Bizantino, che parlava greco, da cui poi si diffuse, attraverso Venezia, in tutta l’Italia settentrionale.
- L’origine dell’espressione ‘Cadere a fagiolo‘ sembra venire dal mondo contadino, perché un tempo i fagioli venivano raccolti quando erano molto maturi: in quella fase, infatti, bastava toccarli appena e i fagioli si staccavano dalla pianta. Cascare a fagiolo o cadere a fagiolo avrebbe così assunto il significato di qualcosa molto opportuna, che rende un problema di facile soluzione, senza sforzo.
- L’ espressione ‘Ad occhio e croce’ ha origine nella Firenze del tardo Medioevo ed è una traduzione della locuzione latina ad oculum [ad occhio]. Infatti, sembra derivare dagli antichi tessitori che, se avessero perso i fili degli orditi, avrebbero dovuto riprenderli ad occhio tenendoli a croce con quelli della trama.
- L’espressione ’Abbiamo fatto trenta, facciamo trentuno‘ è attribuita al pontefice Leone X; questi, durante un concistoro tenuto nel 1517, nominò trenta cardinali. Dopo avere annunciato la nomina dei trenta, si accorse di aver dimenticato un prelato per il quale aveva un’enorme stima; decise quindi di aggiungerlo alla lista e, a chi si stupiva della sua decisione, rispose appunto: “Chi ha fatto trenta può fare trentuno…”.
- ‘Bruciare le tappe‘ significa raggiungere celermente un obiettivo e superare rapidamente una o più tappe. Per garantire una consegna più rapida, i corrieri postali di una volta, molto spesso, evitavano di perdere troppo tempo per ristorare sé stessi e i propri cavalli. La tappa (sosta) veniva in tal modo ‘bruciata’, ‘cancellata’.
- ‘Nuotare nell’oro’ è il tipico esempio di modo di dire che non richiede spiegazioni. L’abbiamo riportato per chiarire il concetto di quali modi di dire siano stati omessi.
- La frase ‘attaccare bottone‘ viene da lontano. Quando l’arte chirurgica non era avanzata come oggi, i sanitari, per cauterizzare le ferite, adoperavano uno strumento di ferro la cui estremità terminava con una sorta di pallottola, simile ad un bottone, che veniva arroventata sul fuoco. Va da sé che il paziente, al quale veniva attaccato il bottone, provava, sia pure per pochissimi secondi, un dolore intensissimo. La locuzione fu poi adoperata, in senso figurato, con il significato di rivolgersi a qualcuno, attaccandolo con discorsi prolissi e noiosi.
- Per quanto riguarda l’espressione ‘essere in gamba’, ci sono due significati a cascata: il secondo significato dipende dal primo. Il primo significato suona come ‘essere in buona salute’, perché chi sta male è spesso costretto a stare a letto. Il secondo significato è un’ estensione del primo: non si ha solo la salute ma anche delle capacità ed ha il significato traslato di ‘stare in piedi da soli’, è quello di sapere e potere risolvere i problemi che si presentano.
- La Chimera (vedi illustrazione) deriva dalla mitologia greca. Si tratta di un orribile mostro, il cui corpo era composto da parti di diversi animali: davanti aveva le fattezze di un leone, al centro di una capra (che spuntava dalla schiena del leone) e dietro di un serpente. Inseguire una chimera vuol dire rincorrere qualcosa che non potrà mai diventare realtà, un’illusione, una vana fantasticheria.
- Si dice che l’espressione ‘Acqua in bocca‘ derivi dalla storia di una donna che non era capace di mantenere dei segreti. Dopo la confessione, il sacerdote le diede una boccetta d’acqua ‘santa’ da bere e da tenere in bocca, nel caso in cui fosse stata assalita dalla voglia di divulgare un segreto. La donna seguì il consiglio, riuscendo a liberarsi dal vizio. Notoriamente, con l’acqua in bocca non si può parlare…
- La spiegazione dell’espressione ‘Chiodo scaccia chiodo‘ è invero complessa e bisogna rifarsi all’Accademia della Crusca. Ne presentiamo qui una piccola parte:
“Con il chiodo il chiodo, con il palo il palo”. Così recita un antico verso proverbiale presente nell’ Onomastikón di Giulio Polluce (9, 120), grammatico e lessicografo del II secolo d. C., che associa il detto al cindalismo (κυνδαλισμός), gioco di destrezza consistente nell’estrarre un chiodo fissato nell’argilla con un altro chiodo: su un terreno umido veniva piantato un chiodo o un piccolo bastone, che doveva essere colpito e rimosso da un altro chiodo o bastone gettato a partire da una certa distanza. Un gioco molto simile, con tanto di premio posto in cima al bastoncino da abbattere, esiste anche in luoghi distanti dalla Grecia, come l’Inghilterra, donde il proverbio inglese: Nail is driven out by nail, and baton by baton [Chiodo da chiodo, bastone da bastone]. L’implicazione è: “Soffrivi per la situazione X: è arrivata la situazione Y ed ora ti trovi ad occuparti di Y e alla situazione X non ci pensi più”. - ‘Fare il cascamorto’ è un’espressione che indica un corteggiatore sdolcinato, languido, che molto spesso assume questo comportamento con diverse donne. Cascamorto richiama l’atteggiamento dello spasimante che sembra morire, venir meno per l’infatuazione.
[segue]
