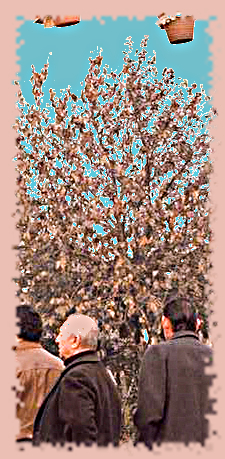
Revisione testo: 16 settembre 2021 – La cultura contadina della Sinistra Piave, appena finita la guerra, cioè nel decennio 1945 – 1955, non era molto diversa dalla stessa di un secolo prima. Questa situazione durò sino al 1962 – 1963, quando si intravvidero all’orizzonte i primi cambiamenti. Si potrebbero esaminare, da un punto di vista antropologico, gli aspetti salienti e farlo inoltre in successione logica, punto per punto: come al nostro solito, procederemo invece in modo semplice e confidenziale, adatto anche ai ragazzi della scuola media.
Affettività, oggi: tramite la televisione, siamo abituati alle madri e ai padri che formano la famiglia perfetta e sbaciucchiano i figli, i quali fanno merenda e vanno a scuola con zaini meravigliosi, efficienti, che distribuiscono il loro peso nel modo il più razionale possibile. Scarpe impermeabili in caso di pioggia, tessuti adatti ma sempre di peso ragionevole, cellulare in tasca e magari lo scuolabus giallissimo che passa a raccogliere i ragazzi… ecco! Consegnati i ragazzi all’ autista, sino all’ora di pranzo non se ne riparlerà.
Affettività, ieri: “Vàrda de mòverte, che to pàre l’è da mèða óra té’l càmp… manchèa ànca ‘sta scuòła… a dièse àni… el sìndaco no l’ha bisògno de méter su pignàta… l’è siór… ièra mèjo se te stèa càsa a iutàrghe a to pàre… ma ormài, co se fa ‘na ròba, mèjo fàrla puìto…” [Guarda di muoverti, ché tuo padre è da mezz’ora nel campo… mancava anche questa scuola… a dieci anni… il sindaco non ha bisogno di mettere su la pentola… è ricco… era meglio se rimanevi a casa ad aiutare tuo padre… ma ormai, quando si fa una cosa è meglio farla bene…]. Merenda: latte e pezzi di polenta avanzati dalla sera prima (pestarèi). Sachéta de cartón, un pèr de calθét de làna s’ciavóna, un pèr de θampièi, braghèsse cùrte sémpro, ‘na màja de sót de làna piègora ðàła, da gratàrse vìa ła prìma pèl sòte i bràθ, ‘na camìsa de flanèa a quadretón, un majonàt a fèri gròssi e, se l’è tànt frèdo, la giachèta che ièra de so pàre mèssa a pósto dal sartór e co ‘na ‘ssiàrpa, anca quèła de làna piègora fàta a màn, còme ła baréta. “Se pióve, te te mète ła sachéta passóra de ła tèsta ma ‘stà ténto a ‘no bagnàrla màssa parchè la è de cartonàt. Guànti no gh’in’è: łe bugànθe le portarà vìa i cavalièri.” [Cartella di cartone, un paio di calzini di lana slava (qualità infima), un paio di zoccoli chiusi sul tallone con una striscia di cuoio, pantaloni corti sempre, una maglia di sotto, di lana grezza, pelosa, gialla, da grattarsi via la prima pelle sotto le ascelle, una camicia di flanella a quadrettoni, un maglionaccio fatto a ferri grossi (per risparmiare lana) e, se fa tanto freddo, la giacca che era di suo padre, sistemata dal sarto e con una sciarpa, anche quella di lana grezza fatta a mano, così come la berretta. Se piove, ti metterai la cartella sopra la testa ma stai attento a non bagnarla troppo perché è di cartonaccio. Quanto ai guanti, non ce ne sono: i geloni saranno portati via dai bachi da seta (dal caldo, in maggio-giugno)]
Il ragazzino, forse commosso da tanta premura o forse per ritardare la partenza ancora per un attimo, fa il gesto di baciare la madre ma viene fulminato:
“Sa fàtu! ‘àtu vòja de far buricinàde? Và vìa, và via che l’è tàrdi…” [Cosa fai! Hai voglia di fare stupidaggini? Vai via, vai via che è tardi…]
Questa era l’affettività, anche tra marito e moglie. Gli argomenti sui sentimenti non esistevano. Questo atteggiamento abituava ad essere tetragoni di fonte alle avversità della vita. Avversità che si verificavano ad ogni piè sospinto, in continuazione.
In tanti pranzi ai quali ho partecipato nelle case patriarcali dei contadini, quando la moglie attendeva un complimento dal marito (che tornava dai campi) per le sue arti culinarie, il massimo che poteva aspettarsi era: “Ho lavorà cóme un mùss e tìre el fià te un cónθ… magàri l’è par quél che càte tùt bón…” [Ho lavorato come un somaro e respiro come se avessi la testa nel mastello alto, quello della prima spremitura, pieno di anidride carbonica (cioè respiro malissimo dalla stanchezza), magari è per questo che trovo tutto buono…]
In tanti anni vissuti con mia nonna, non l’ho mai sentita dire che mangiava qualcosa volentieri: sarebbe stato violare un tacito patto col mostro invisibile della fame. Pertanto, diceva sempre e soltanto, a sua giustificazione, con voce stentòrea, in modo che il mostro sicuramente intendesse: “Me tóca magnàr calcòssa parché son ðó de le mée…” [Devo mangiare qualcosa perché sono giù delle mie forze]. In tal modo, il mostro della fame non avrebbe avuto il coraggio di vendicarsi, perché mia nonna mangiava solo per sopravvivere e non certo per concedersi una forma di lusso.
