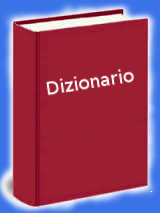 Revisione del 23 dicembre 2020 – Facciamo seguito al precedente Nuovo Dizionario 2 [245], illustrando una serie di parole che dimostrano come il dialetto veneto sia, certe volte, più interessante della lingua italiana: quindi il dialetto veneto non è un parente povero, come molti credono; è piuttosto un aspetto evoluto e con collegamenti originali con le lingue latina, greca e così via.
Revisione del 23 dicembre 2020 – Facciamo seguito al precedente Nuovo Dizionario 2 [245], illustrando una serie di parole che dimostrano come il dialetto veneto sia, certe volte, più interessante della lingua italiana: quindi il dialetto veneto non è un parente povero, come molti credono; è piuttosto un aspetto evoluto e con collegamenti originali con le lingue latina, greca e così via.
Una disputa del XVI° secolo, durata anni, doveva decidere se utilizzare il veneto oppure il fiorentino come lingua per tutta l’Italia. Poi l’Accademia della Crusca (di Firenze…), decise per… indovinate…
Bagìgio, anche babagìgio o barbagìgio: parola maschile, arachide, nocciolina americana. La parola viene dall’arabo habb aziz, mandorla buona. In italiano abbiamo invece aràchide, sostantivo femminile. Quest’ultima viene dal greco a–rhàkhis, (a=senza, rhàkis=spina dorsale), perché i suoi fiori sono privi di sostegno. Come si vede, l’origine dei due termini è diverso ma quello veneto non è meno nobile di quello italiano e, forse, dal significato più piacevole: ‘mandorla buona’ non è neanche da confrontare con la dicitura ‘senza spina dorsale’.
Borétoła: lucertola (lacertìlia), forse dal greco bor – taomai, (bor=facilmente, rafforzativo, e taomai= tagliare, perdere), perdere facilmente (la coda). Stessa costruzione si ha per borborìo, ramarro occidentale (lacerta bilineata), cioè lucertola gialla e verde (verde il dorso e giallo il ventre), dove addirittura il rafforzativo bor viene reiterato a sua volta. Lucertola invece è un diminutivo del termine latino lacerta. La strada presa dalle parole venete è molte volte più direttamente connessa al greco, forse per la maggior frequentazione veneta coi bizantini che parlavano per l’appunto il greco.
Fiłò: veglia serotina invernale nella stalla, molto probabilmente dal greco filìa, amicizia. Potrebbe essere anche dal latino filare o filum, lavorare alla filatura della lana (come si faceva una volta nelle stalle), anche se meno probabile. Pure in questo caso, l’origine della parola può dipendere dai contatti coi bizantini.
Gałéna: tartaruga (testudines), si usa ancora vicino a Chioggia, nella bassa padovana e nel rovigotto. Citiamo questa parola perché i ruoli si invertono. Mentre l’italiano tartaruga viene dal greco Tartarùkhos, nome di un essere immondo, un essere che abita il Tartaro, realtà tenebrosa e sotterranea, il veneto gałéna viene invece dal latino galéa, elmo di cuoio o di metallo, elmo che ricorda la corazza dell’animale. Come si vede, non sempre il veneto è più vicino al greco dell’italiano. Faccio notare, scherzosamente, che il termine veneto è più rispettoso dell’animale…
Grébano o glébano: contadino legato spregiativamente alla terra, dal latino gleba (= zolla di terra). Si usa per dire maleducato, rozzo.
Góndoła: la storia apparentemente semplice della parola è il latino cumba (barca) > cymbula (diminutivo, barca piccola). Poi, cymbula > gumbula > gundula > gondola. Come accade spesso nel dialetto veneto, la cy di cymbula diventa facilissimamente gu: rispettivamente, c diventa g e y diventa u, inoltre b che diventa d è comunissimo. Vedi, ad esempio, tutte le k greche che, spostandosi verso occidente, si addolciscono in b (esempio kerberos > berberos: kerberos, il mostro rutilante nei suoi colori, berberos, i popoli coi mantelli colorati. Poi, col tempo, il veneto trasforma spesso le u in o (ed anche l’italiano, vedi multus > molto, sorbus > sorbo, populus > pioppo, etc.). Per ulteriori approfondimenti, vedere in bibliografia i libri di Benveniste. N.b. il segno ‘>’ è leggibile ‘che diventa’.
Marθariòl, maθariòl: dal latino marzius (di marzo, marzaiolo), diavoletto dispettoso che compare soprattutto in marzo (dato il nome) con l’arrivo della primavera, di cui abbiamo parlato altrove.
Rùmoła: talpa (talpa europaea). Il termine veneto viene dal latino rimare, che significa scavare, rovesciare, mettere sottosopra. Rimare > rumare > rùmola. Anche talpa viene dal latino, che a sua volta viene dal greco kalpa o skalpa, l’animale che scava (come scalpello). In dialetto, si usa quindi una parola di origine lontanissima ma non diversa dall’italiano, anche se le due parole sono completamente differenti.
Sórθ: sorcio, topo (apodemus sylvaticum), dal latino mus sorgi (topolino del sorgo), mus sorgi > sorgi > sórθ. L’italiano usa invece ‘topo’, che, incredibilmente, viene da talpa > talpum > topum (latino volgare). Il veneto quindi ha un termine, sórθ, che è più appropriato, mentre l’italiano collega stranamente il termine talpa al termine topo.
Spièra: ‘na spièra de sól, un raggio di sole da una fessura di una finestra. Viene dal latino speculum, specchio, riflesso. L‘italiano è sprovvisto di un termine unico con lo stesso significato. Molte sono le parole che esistono in veneto ma che non hanno termine corrispondente in italiano, se non usando una circonlocuzione, ovvero un giro di parole. Ad esempio, il classico termine veneto freschìn non ha equivalente in lingua italiana, né, a quanto sembra, in alte lingue indoeuropee. Per tradurre l’esatto significato, bisognerebbe dire: “Spiacevolissimo odore che si riceve da piatti, bicchieri e stoviglie in genere, quando gli stessi abbiano ospitato delle uova e che poi siano stati lavati male.”
Tamìso: viene dal tardissimo latino medievale parlato ‘tamisium’, a sua volta dal gallico o franco tamis (setaccio, crivello). Setaccio viene a sua volta dal tardo latino saetacium, che deriva da saeta, setola, crine. Crivello viene a sua volta dal tardo latino cribellum, diminutivo di cribrum (=vaglio).
