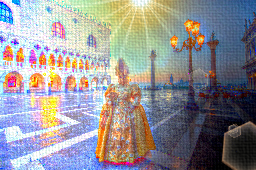
Revisione testo: 2 dicembre 2021 – Vedere anche i blogs precedenti (ultimo dei quali, Altri Giochi psicologici 6, che in particolare contiene la prima parte del Gioco della Calza).
Il Gioco della Calza, approfondimento a richiesta di molti lettori.
Per approfondire, dobbiamo innanzi tutto parlare di cosa pensa una persona, inconsciamente, di sé stessa e del suo interlocutore. Tenete presente che l’inconscio di ogni persona non ha il senso del tempo e non ha scale di valutazione: l’inconscio usa SEMPRE e MAI, non è cioè capace di concepire misure relative intermedie. Si tratta quindi di una dicotomia valutativa, ovvero l’inconscio valuta solo in due modi, ignorando le misure intermedie. Il tempo dell’inconscio è il presente, l’ OGGI. Questo è un retaggio di quando eravamo animali mammiferi senza il neopallio. L’inconscio quindi è un essere che è contemporaneamente appena nato, ragazzino, adolescente, adulto, anziano, vecchio e in punto di morte. Tutto questo sempre e soltanto oggi. Quando pensa ad un familiare, anche se lo stesso non c’è più perché è morto da tempo, lo pensa come se fosse una persona ancora viva. Un torto subito cinquant’ anni fa è tuttora presente e non può essere eliminato. Viene dimenticato, fatto sparire dalla parte conscia, per ragioni di opportunità, decise involontariamente dall’ inconscio ma il torto è sempre là, in cantina, anche se rinchiuso a chiave e continua a disturbare il nostro essere, magari con forme di psoriasi ed altre cose del genere. A causa della struttura fisica del corpo umano, il cosiddetto esofoglietto (uno dei tre foglietti esistenti) comprende, assieme al cervello, anche l’epidermide: è probabile quindi che la pelle possa risentire molto facilmente di traumi psichici lontani nel tempo.

Carl Gustav Jung (1875-1961), psichiatra, psicoanalista e soprattutto antropologo svizzero, offre l’immagine di uno stagno (per rappresentare il corpo umano), dove nel profondo dello stesso sono sepolti, come se fossero delle pietre, i torti o le vicissitudini negative da noi subiti: ebbene, tali torti lasciano andare periodicamente delle bolle d’aria mefitica, che affiorano, esplodendo sulla superficie dello stagno. La superficie dello stagno è la nostra epidermide. Una volta subito il torto e, in particolare, se subito più volte, il nostro inconscio è sempre in allerta ed è convinto che la vendetta sia il prezzo da far pagare al nostro Persecutore, perché il nostro inconscio è sempre convinto di essere la Vittima; non considera mai sé stesso come un Persecutore, anche se, come abbiamo visto (e come vedremo), nel Gioco della Calza (come d’altronde in tutti gli altri Giochi), il giocatore-Vittima diventa Persecutore, anche se non se ne rende conto perché in quel momento sta esercitando la vendetta. Ogni tanto, la Vittima cerca qualche Salvatore ma se il comportamento del Salvatore non è ineccepibile, l’inconscio è molto vendicativo e tende a considerare anche il Salvatore come un altro Persecutore. Quando il giocatore (della Calza, nel nostro esempio) si vendica, non lo fa necessariamente col vero responsabile delle sue disgrazie ma lo fa col primo che trova, perché la vendetta DEVE essere portata avanti, per far scoppiare le bolle che affiorano, nei confronti del malcapitato presente in quella circostanza. Ovviamente, subito dopo, il giocatore (o la giocatrice della Calza) si rendono conto di aver fatto del male ad una persona innocente e questo aggiunge, nel fondo del lago, un’altra pietra velenosa che scaturirà altre bolle, oltre alle precedenti.
Quando il fondo del lago ha un certo numero di pietre-rimorsi, l’individuo dà un giudizio estremamente negativo su sé stesso e decide di punirsi: una bella malattia, un’ invalidità, un suicidio e così via, benché all’ origine il problema sia nato magari da familiari malaccorti e non da comportamenti sbagliati della nostra Maria.
Queste cose, a scanso di equivoci, le abbiamo tutti: e tutti vuol dire proprio tutti. L‘inconscio di chi sta leggendo penserà immediatamente: “Tutti? sarà… tranne me, ovviamente…”
Le abbiamo invece proprio tutti perché sono il risultato di equilibri raggiunti per sopravvivere, dalla notte dei tempi. E allora, come fare? non c’è soluzione, però conoscere queste cose è importantissimo. Non siamo pertanto responsabili, come purtroppo dicono i preti per terrorizzarci, di ciò che pensiamo ma solo di ciò che facciamo. E allora, perché i preti ci dicono questo? perché il popolo che vive nella paura è più gestibile, più mansueto, più pronto ad obbedire e anche il politico fa esattamente questo. Una questione di comando, quindi. Chi non ha paura, ride. Chi ride, ride perché ha imparato e avrà quindi più frecce nel suo arco, sopravviverà meglio, riderà meglio e avrà ancora meno paura, obbedirà meno ad insegnamenti e a comandi insensati. (Aristotele, II)
Il nostro comportamento, invece, sia il seguente: “Mi devo ricordare che la mia mente inconscia reagisce indipendentemente dalla mia volontà e non è da me controllabile: non posso rispondere di quello che penso e non mi devo sentire in colpa per i miei pensieri perché l’inconscio ha mandato avanti la nostra specie comportandosi in questo modo. E tanto meno devo dare un giudizio negativo sull’ inconscio, perché è quello che chiude gli occhi se mi lanciano una pallottolina di carta verso il viso e li chiude prima ancora che io me ne renda conto. Si scansa se mi lanciano un oggetto contro prima ancora che io me ne accorga e toglie le mani dal fuoco prima che io me ne renda conto. Si tratta quindi di un amico scimmione, istintivo, che viene dalla notte dei tempi. Devo cercare di parlargli, di essere suo amico e cercare di capirlo, perché anche lui ha i suoi desideri e, se possibile, devo cercare di assecondarlo. Io sono responsabile esclusivamente di ciò che faccio e non di quello che penso. Devo cercare di ricordarmelo”.
Cito, a questo proposito, prima di riprendere con Maria e con il Gioco della Calza, un episodio che dovrebbe far riflettere, il quale episodio non è altro che una variante analoga alle cause che possono far scaturire il Gioco della Calza.
Una ragazza, Angela, si drogava: era una bella ragazza, di famiglia benestante; una ragazza intelligente, che poteva chiedere alla vita un suo posto piacevole.
Interrogata sul perché si drogasse, rispondeva che non lo sapeva bene ma che era per far sì che una parte di sé stessa fosse più tranquilla, che non disturbasse.
Chiaramente, c’era di mezzo l’inconscio. L’ ipnotista le indusse un rilassamento profondo e il suo inconscio parlò: “Angela ed io ci droghiamo tanto per fare qualcosa, io volevo una borsetta rossa, Angela voleva accontentarmi, nostra madre ci ha detto che una borsetta rossa è un desiderio da ragazza poco seria. Non è giusto, perché non è vero. Una madre così sarebbe da uccidere. La droga ci aiuta molto a non fare vendetta e a lasciare nostra madre in vita.”
Risvegliata la ragazza (che non ricordava assolutamente niente), le fu suggerito: “Perché non ti compri una bellissima borsetta rossa e non la mostri a tua madre?”. Rimase per un minuto buono con la bocca aperta a pensare. Poi si alzò di scatto, andò a comperarsi una bella borsetta rossa e la mostrò alla madre, la quale nemmeno si ricordava della proibizione. La madre disse: “Bellissima questa borsetta rossa… è un regalo per te o è un regalo per me?”. La ragazza approfittò e disse: “Mamma, è un regalo per te.”
La mamma: “Grazie, Angela, non te lo avevo mai detto ma avevo sempre sognato una borsetta rossa.”
Che la proibizione venisse dalla nonna di Angela? e chi lo sa? ma ci si può rovinare la vita con la droga per una idiozia del genere? in questo caso, sembrerebbe di sì…
La ragazza, a quanto risulta, non s’è drogata mai più. Questo caso è stato esposto perché le vie dell’inconscio sono infinite. E pure è infinita la trasmissione per settanta volte sette generazioni, come dice qualcuno.
Tornando all’ inconscio e ai nostri Giochi, vediamo le quattro posizioni fondamentali di chi gioca. (Vedere bibliografia, Eric Berne). Notate l’uso di SEMPRE e MAI:
- Io sono SEMPRE all’altezza della situazione e tu sei SEMPRE all’altezza della situazione.
- Io non sono MAI all’altezza della situazione e tu non sei MAI all’altezza della situazione.
- Io sono SEMPRE all’altezza della situazione e tu non sei MAI all’altezza della situazione.
- Io non sono MAI all’altezza della situazione e tu sei SEMPRE all’altezza della situazione.
La giocatrice della Calza, come abbiamo visto, di solito, pensa di essere, col suo interlocutore, nel caso 4. Questo inasprisce la sua rabbia e il suo desiderio di vendetta ancora di più. Vuole dimostrare al mondo che si trova, non nel caso 1 ma per vendicarsi ma nel caso 3 e per far questo deve primamente distruggere la posizione dell’interlocutore, portandolo a passare, lui pure, dal caso 4 al caso 3. Passata al caso 3, e fatto passare alla parte complementare del caso 3 l’ interlocutore, Maria ha esercitato la sua vendetta. Purtroppo, chi esercita la vendetta, dopo un poco, a mente fredda, si accorge che non si trova nel caso 3, ma piuttosto nel caso 2, dove in realtà la nostra giocatrice continua a non essere all’altezza della situazione.
Non si arriva al caso 1 se non quando Maria si rende conto di quanto sta succedendo, inconsciamente e anche consciamente.
Il caso 3 è comunque il caso più pericoloso perché viene anche definito l’ Atteggiamento Nazista: io sono un super-uomo e tu non sei nessuno, posso metterti anche nella camera a gas così non vedrò più la tua brutta faccia.
Accennando al Copione, che sembra essere molto interessante per i nostri lettori, diremo che un poco alla volta, dall’infanzia, i genitori (o i familiari) scrivono il Copione del figlio, la parte cioè che Maria dovrà recitare nella vita.
Altro esempio di Copione:
Una mia seconda cugina, che faceva l’infermiera, aveva il seguente Copione: “Ti sposerai con un alcoolizzato, lo aiuterai, soffrirai, perché anch’ io, tua madre, con mio padre (cioè con tuo nonno) ho dovuto fare così e, dopo averlo sposato, lo seppellirai. Questo compenserà eventuali mancanze e disattenzioni che io ho avuto nei confronti di tuo nonno, cioè mio padre. Tu mi devi riscattare. Sulla tua tomba starà scritto: qui giace Luigia, una brava ragazza, che ha fatto di tutto per minimizzare gli errori di sua madre nei confronti di suo nonno”. Ebbene, Luigia ha sposato tre alcoolizzati e li ha sepolti tutti e tre. In quattro anni. Incredibile. Probabilmente aveva scelto la professione d’infermiera per trovarli meglio…
A questo punto, mia nonna Epo mi disse di dirle: “Te ha nàso par catàrli ma te podarìe ‘vèr el stésso nàso par schivàrli… no te pàr de ‘vér pagà bastànθa el cónto de to màre?” [Hai naso per trovarli (gli alcolizzati) ma potresti avere lo stesso naso per evitarli… non ti sembra di aver pagato abbastanza il conto di tua madre?]
Luigia rimase come folgorata. Si è sposata poi con un uomo normale.
Maria è destinata ad avere, sul suo epitaffio, la scritta: “Qui giace una ragazza innocente che, distrutta dai suoi genitori, ha passato la sua vita a vendicarsi con degli innocenti per cose estranee al loro comportamento. La sua colpa è stata di non capire che lei poteva essere SEMPRE all’altezza delle varie situazioni e che poteva trovarsi un compagno, pure all’altezza SEMPRE delle situazioni.”
Ma sappiamo che SEMPRE e MAI non si debbono usare, e quindi basta che il SEMPRE diventi DI FREQUENTE, SPESSO. C’è una sola frase in cui si possono usare SEMPRE e MAI:
“Ricordati SEMPRE di non dire MAI le parole SEMPRE e MAI”.
Maria quindi, con infinita pazienza, deve riflettere e scrivere sul suo epitaffio:
“Qui giace una bella donna che per un lungo periodo ha fatto il Gioco della Calza, facendosi un sacco di nemici. Lo faceva per vendicarsi con l’umanità per torti subiti nell’ infanzia da genitori poco avveduti. Poi si è accorta che, purtroppo, la sua infanzia felice non sarebbe mai più ritornata comunque. C’è chi ha malattie genetiche, chi ha difetti fisici: lei non ha avuto l’infanzia. Se ne è fatta una ragione ed ha cercato di non trasmettere questa tara vendicativa ai figli. Questo è il suo grande merito.”
I problemi qui esposti, purtroppo, se non si fa attenzione, vengono trasmessi ai figli, così come la madre di Luigia aveva trasmesso a Luigia stessa il suo problema avuto col proprio padre, nonno di Luigia e così come la Borsetta Rossa veniva forse dalla nonna della nonna della nonna.
Se non bastasse, un ultimo esempio che si trova molto comunemente nelle famiglie venete. A Venezia, una coppia di sposi aveva due figlie, chiamiamole PiuVecchia e PiuGiovane.
Nel Copione della PiuVecchia c’era scritto: “Divertiti, anche per noi, ché non ci siamo mai divertiti.” Nel Copione della PiuGiovane c’era scritto: “Quando avremo problemi di salute o di anzianità, ci rivolgeremo sempre e solo a te.”
Questi Copioni, come avrete capito, non erano in realtà scritti ma erano stati inculcati ostinatamente e con monotonia, per anni, nella testa delle figlie, le quali in linea di massima avevano anche accettato, in particolare la più grande, che aveva per sua fortuna un copione piacevolissimo.
Succede che, una volta, le due figlie fanno una domenica fuori porta coi rispettivi fidanzati.
Al ritorno, alla sera, mamma e papà si informano con la PiuGrande:
“Ti te gavarà divertìo, véro, sperémo bén, parchè nuiàltri, da séno, gavémo vùo póchi divertiménti, almanco divèrtite ti...” [Ti sarai divertita, vero, speriamo bene, perché noialtri, in verità, abbiamo avuto pochi divertimenti, almeno fallo tu…]
Poi, con la PiuPiccola:
“Ti xe ‘ndàda vìa, sénsa pensàr che nuiàltri sémo vèci e abandonài, no te interéssa se par càso stémo mal, se ne sucéde calcòssa… ti ga pròpio un bel coràgio…” [Sei andata via, senza pensare che noialtri siamo vecchi e abbandonati, non t’interessa se per caso stiamo male, se ci succede qualcosa… hai proprio un bel coraggio…]
PiuPiccola: “Ma ‘na vòlta, no podaréssi farghe ànca a me sorèła el stésso discórso…” [Ma per una volta, non potreste fare anche a mia sorella questo stesso discorso…]
Genitori: “Eh… ma xè n’àltra ròba, sé do persóne divèrse… se pròpio gavéssimo da ‘vér bisògno, to sorèła ne iutarìa de sicùro…” [Eh… ma è un’altra cosa, siete due persone diverse… se proprio dovessimo aver bisogno, tua sorella ci aiuterebbe di sicuro…” .
Mi sembra che ogni commento sull’irrazionalità dell’ultima frase, qui sopra, sia superfluo.
